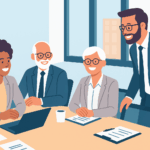In passato era relativamente facile mantenere una distinzione netta fra identità personale del CEO e identità corporativa del brand. Le “facce dell’azienda” erano mediatori (portavoce, ufficio stampa, board) che filtravano messaggi istituzionali, e le aziende si proteggevano dietro loghi, mission, mission statements, valori aziendali.
Ma oggi, con social media, dirette streaming, algoritmi di visibilità e una cultura del “dietro le quinte”, quel filtro si assottiglia. Il CEO che dialoga su LinkedIn, che posta storie su Instagram, che reagisce in prima persona alle critiche non è più un’eccezione, è spesso l’asset comunicativo più potente del brand.
E questo comporta due ordini di sfide:
- Sinergie e contaminazioni: la reputazione del leader diventa reputazione del brand (e viceversa).
- Rischi esponenziali: una gaffe, un comportamento impulsivo, una scelta eticamente controversa del CEO si riverbera immediatamente sul brand.
I casi recenti lo dimostrano con chiarezza.
Il caso Drogbruk: un CEO che “ruba un cappellino” e distrugge rating
Nelle ultime settimane è divenuto virale il video di Piotr Szczerek, CEO dell’azienda polacca Drogbruk. Durante gli US Open, gli fu fatto notare che un bambino stava tentando di ottenere il cappellino del tennista Kamil Majchrzak; Szczerek glielo sottrasse con un gesto brusco, le telecamere ripresero tutto, il video girò sui social. La reazione del pubblico fu furiosa.
Le conseguenze?
- Le recensioni su Google per Drogbruk precipitarono a 1,3 stelle.
- Trustpilot sospese il rating per l’ondata massiccia di commenti negativi.
- Il CEO si vide costretto a scuse pubbliche: “Non era mia intenzione, ma ho ferito il ragazzo e deluso i tifosi.”
Questo episodio illustra in modo plastico quanto il confine identitario fra l’uomo e l’azienda sia oggi sottile. Non si tratta solo di “gesto cattivo del CEO, problema del CEO”: gli utenti non fanno distinzione, e il brand – per molti – è il CEO (o almeno ne riflette valori e stile).

Il caso Amabile / Martina Strazzer: storytelling vs. contraddizione pratica
In Italia un caso simile — sebbene meno drammatico — è esploso intorno a Martina Strazzer e il suo brand di gioielli Amabile.
- Strazzer aveva annunciato pubblicamente, sui social, l’assunzione di una dipendente già incinta come “atto di valore” e simbolo di inclusione (empowerment femminile).
- Ma, alla scadenza del contratto, la stessa dipendente (Sara) non venne confermata. La decisione venne percepita come dissonante rispetto al racconto valoriale dell’azienda.
- La vicenda deflagrò sui social: perdite di follower, accuse di “purpose washing” (uso strumentale di valori sociali come veicolo promozionale), e forte pressione mediatica.
- Strazzer, silente per giorni, ritornò al discorso pubblico con un lungo comunicato e infine con un’intervista. Parlò di responsabilità, di “scelta difficile”, e affermò che la gravidanza non c’entrava.
Questo episodio rivela quanto la “narrazione valoriale” del brand sia fragile se non è coerente con le pratiche reali, e quanto la persona che è quel brand (e che lo comunica) debba essere allineata in ogni suo gesto — pubblico e privato.

Il caso “Kiss Cam” Coldplay: quando la vita privata e aziendale si confondono
Un ultimo caso emblematico: durante un concerto dei Coldplay, una “kiss cam” inquadrò Andy Byron, CEO di Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda, in un momento affettuoso. Il video divenne virale.
- Byron rassegnò le dimissioni.
- Cabot in un primo momento rimase “sospesa”, ma successivamente anche lei lasciò l’azienda.
- La reazione dell’azienda fu cauta: non bastava lo scandalo, dovevano esserci valutazioni contrattuali, indagini interne, rispetto delle procedure.
Questo caso evidenzia che la distinzione tra “vita privata” e “ruolo pubblico aziendale” è diventata in molti casi impalpabile (o imposta dalla visibilità). Qualunque cosa fanno i “volti” dei grandi brand e dei grandi progetti imprenditoriali, può essere amplificata e interpretata come performance aziendale.

Le lezioni per la comunicazione e il branding oggi
A partire da questi esempi possiamo ricavare alcune riflessioni utili per chi governa la comunicazione di aziende, brand e leader:
1. Il leader è spesso la “firma umana” del brand
Quando il CEO è anche personal brand (e sui social si esprime direttamente), diventa portavoce immediato dell’identità del marchio. I suoi comportamenti — anche personali — si assumono come indici di coerenza (o incoerenza).
Quindi, ogni gesto pubblico del leader ha valenza comunicativa, che va considerata nel piano di reputazione.
2. Coerenza narrativa → coerenza pratica
Non basta promuovere “valori” su post, story, copy. Se le pratiche interne (HR, politiche aziendali, assunzioni, turn over) non riflettono quei valori, la dissonanza si traduce in crisi reputazionale.
3. La trasparenza è arma a doppio taglio
Essere “aperti” è oggi un vantaggio: il pubblico vuole vedere il dietro le quinte, ascoltare il CEO, sentirne l’umanità. Ma trasparenza non significa totale esposizione senza limiti: serve gestire con saggezza cosa far diventare pubblico e cosa deve restare “privato”.
4. Il CEO come “mediatore emozionale”
Nell’era digitale, il pubblico non chiede solo prodotti, ma relazioni, storie. Il CEO può veicolare queste relazioni: mostrando passioni, errori, visioni. Ma dev’essere autenticità, non recita scenografica.
5. Crisi reputazionali personali = crisi reputazionali aziendali
Non separare troppo le strategie di crisi aziendale da quelle del personal branding del CEO. Salvaguardare uno significa proteggere l’altro.
Verso una nuova simbiosi identitaria
Il confine fra il CEO e l’azienda che dirige è sempre più permeabile nell’epoca della democrazia digitale. Il branding aziendale non può più essere slegato dall’identità personale del suo portavoce principale. Questo richiede, da parte delle organizzazioni, una visione integrata: strategie di comunicazione che tengano insieme “noi azienda” e “io persona”.
Le crisi recenti (Drogbruk, Amabile, il caso Kiss Cam) non sono incidenti isolati: sono segnali di un’epoca in cui le “identità sospese” devono essere gestite con consapevolezza, trasparenza e coerenza. Per chi guida un’impresa, presiedere la propria presenza online non è un “plus”, è parte essenziale del mestiere. E la differenza fra “leadership corporea” e “leadership storytelling” può davvero determinare il successo o il tonfo reputazionale.