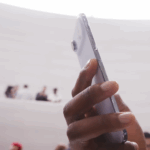Ormai si sa: l’interesse per il “rigenerativo” sta esplodendo in Europa. Ricercatori, policy maker e filiere stanno spingendo pratiche orientate alla salute del suolo e alla resilienza climatica. La domanda giusta non è se sia di moda, ma se possa davvero cambiare gli economics delle aziende agricole. Nature fotografa il momento: un’ondata di pratiche per suolo, redditività e adattamento climatico sta arrivando nelle campagne europee.
L’approccio “Rigenerativo” non è un singolo metodo: è un insieme di pratiche (cover crops, rotazioni evolute, minime lavorazioni contestualizzate, integrazione agroforestale, gestione mirata degli input, reintegrazione della sostanza organica) con obiettivi misurabili su suolo, acqua, biodiversità e redditività. La FAO lo definisce come approccio olistico che migliora qualità di acqua e aria, biodiversità, nutrient density e stoccaggio di carbonio, mantenendo la sostenibilità economica dell’azienda.
“Regenerative agriculture describes holistic farming systems that, among other benefits, improve water and air quality, enhance ecosystem biodiversity, produce nutrient-dense food, and store carbon to help mitigate the effects of climate change. These farm systems are designed to work in harmony with nature, while also maintaining and improving economic viability.” – FAO 2022
Nel breve periodo, l’adozione può comportare costi di transizione e leggere flessioni di resa; nel medio termine, però, riduce la dipendenza da input esterni, migliora la ritenzione idrica e stabilizza la produttività. Gli investitori iniziano a premiare pratiche rigenerative, ma senza una reale condivisione dei costi la transizione non scala.
Potenziale climatico ed economico
Il comparto agricolo ha un potenziale di mitigazione stimato tra 8 e 14 GtCO₂e/anno al 2030-2050, con la gestione del carbonio nei suoli come uno dei principali driver. Ma l’IPCC avverte: senza monitoraggio e verifiche solide, il rischio è che si vendano promesse vuote.
Anche l’Europa si muove: la nuova PAC introduce gli eco-schemes per pagare pratiche come coperture vegetali e agroforestazione, mentre la Soil Strategy 2030 e la nuova legge sul monitoraggio dei suoli puntano a definire standard comuni. Sono strumenti fondamentali per dare basi concrete al rigenerativo, anche se restano gap tra incentivi PAC e obiettivi climatici.
Evidenze e casi italiani
Le meta-analisi confermano i benefici su carbonio organico e resilienza quando le pratiche vengono adottate come sistema e non come tattiche isolate. L’integrazione colture-zootecnia, ad esempio, può aumentare carbonio nel suolo e biodiversità, ma da sola non basta a compensare il metano: serve una gestione complessiva.
In Italia si stanno muovendo reti multi-attore, specie in Veneto e Friuli, che collegano agricoltori, industria, ONG e brand per garantire materie prime coltivate con standard rigenerativi. È questa la strada per rendere credibile il cambiamento: domanda contrattualizzata, supporto tecnico e premi di prezzo.
Da slogan a modello concreto
Il rischio più grande è che il termine “rigenerativo” diventi marketing: servono criteri chiari, misurazioni trasparenti e incentivi legati ai risultati. Non basta pagare la pratica: bisogna pagare la performance, con indicatori su suolo, acqua e biodiversità.
Se ben progettata, l’agricoltura rigenerativa non è solo un miglioramento ambientale, ma un’innovazione di modello: sposta valore dal volume di input alla salute dell’ecosistema aziendale, riduce i rischi climatici e apre a nuove forme di redditività. È una leva concreta per rimettere in equilibrio redditività, resilienza e risorse del settore.