Apple non sta “fallendo”. Sta diventando qualcos’altro: una macchina di bilancio che misura il successo a colpi di EPS, buyback e ARPU. È l’opposto della Cupertino di Jobs, che partiva dal “perché” del prodotto e lasciava che la finanza seguisse. Il cambio di rotta è databile: 2012. Da allora Apple riapre il rubinetto dei dividendi e varo dei riacquisti di azioni—una scelta che Jobs aveva sempre rimandato. È scritto in chiaro nel comunicato ufficiale: dividendo trimestrale e primo buyback da 10 miliardi.
Da lì in poi la leva finanziaria diventa protagonista. Nel 2024 Apple autorizza il più grande buyback della storia USA: 110 miliardi; nel 2025 altri 100 miliardi. Non sono numeri marginali: sono la tesi strategica.
Questo nuovo Apple “per gli azionisti” conquista anche Buffett—che per decenni aveva evitato il tech “che non capiva”—e che entra nel 2016 con la prima tranche da ~1 miliardo. Traduco: se il re del cash flow compra, vuol dire che l’azienda si comporta come una consumer/finance company più che come un laboratorio di frontiera.
Dalla creazione di valore alla gestione del valore
Jobs usava il prodotto per creare valore d’impresa; Cook usa la finanza per estrarlo. Il risultato è un gigantesco trasferimento di capitale dal rischio (scommesse di lungo periodo) al rendimento immediato (EPS accresciuto da riacquisti). Sì, la R&D è salita—> 31–33 miliardi nel 2024–25—ma il segnale che percepisce il mercato non è “nuova categoria rivoluzionaria”, è “ottimizzazione e servizi”.
Nel frattempo i Servizi esplodono per fatturato e margini >70%, diventando il pilastro della valutazione. Ma sono anche il fianco scoperto: App Store e intesa di ricerca con Google sono sotto tiro regolatorio in USA ed EU. Margini facili, rischi legali alti.
Cultura: quando la finanza mette il cappello al design
La storia interna è nota: dopo la morte di Jobs, il design, che ha sempre rappresentato un punto di forza per Apple, perde centralità; Jony Ive si logora tra attriti con operations/finance e nel 2019 se ne va. Non è gossip: è documentato (con tutte le smentite di rito). È il simbolo di uno spostamento di potere dal “che cosa e perché” al “quanto costa e quando esce”.
Prodotto: crescere alzando i prezzi, non alzando l’asticella
Tra iPhone 6/6s/7/8 l’inerzia estetica si è vista. Poi la vera leva di crescita è stata il prezzo: iPhone X inaugura lo sconto psicologico dei 1.000$ nel 2017; oggi il top di gamma va a 1.199$ e l’ASP globale supera 900$. Innovazione percepita? Sempre più incrementale; monetizzazione? Eccellente.
Posizionamento: da poche icone chiare a un listino confuso
Il brand creato da Jobs viveva di estrema semplicità: poche linee, ruoli chiarissimi. Oggi la griglia è diventata Pro/Max/Plus/Ultra/Air/SE (e domani “Air” al posto del Plus secondo le anticipazioni). È segnale di architettura di offerta difensiva, fatta per segmentare prezzo e cannibalizzazione, non per raccontare un’idea unica. Lo stesso fenomeno avviene anche nel mercato automobilistico.
Prestigio intatto, leadership incrinata
Apple resta un gigante, ma non è più l’asse del mercato: nel 2025 è terza per capitalizzazione dopo Microsoft e Nvidia. In parallelo, l’AI—vera narrativa di mercato—l’ha presa in contropiede sul piano del timing. Oggi OpenAI innova e si insedia all’interno del mondo personale e professionale, mentre Siri fatica a far partire una chiamata correttamente. Cosa avrebbe detto Steve Jobs?
Le implicazioni di un capitalismo “da trimestrale”
- Meno rischio imprenditoriale: se il capitale in eccesso torna agli azionisti, non finanzia l’innovazione. La TESI è chiara: buyback record, nessuna categoria nuova dominante dal 2015 (l’anno di Apple Watch ed AirPods).
- Innovazione “misurata”: R&D cresce, ma è allocata su chip proprietari, supply chain e servizi—ottimo per margini, tiepido per la magia del prodotto.
- Brand dilution: lineup più larga = posizionamento meno netto. Se la promessa di brand diventa “paghi di più per avere un po’ di più”, la differenza percepita con Android premium si assottiglia. (Le indiscrezioni su “iPhone 17 Air” accentuano il mosaico.)
- Dipendenza regolatoria: se l’equity story si poggia su servizi ad altissimo margine, ogni colpo ad App Store/search si riflette diretto sui multipli.
“Che fare” (se Apple volesse tornare a creare valore, non solo profitti)
- Tagliare i buyback a soglia e vincolare il differenziale a un fondo “skunkworks” pluriennale (10 anni) su 2–3 scommesse di piattaforma: personal AI on‑device realmente privata; salute avanzata non medical‑toy; AR leggera (non “caschi”).
- Ricompattare il listino in tre famiglie leggibili (Base / Air / Pro) con regole semplici e cicli di redesign dichiarati: quando tutto è “Pro”, niente è “Pro”. (L’idea di un “Air” ha senso solo se ridefinisce il linguaggio formale, non se è un rebadge del Plus.)
- Prezzi stabili per ciclo: blocco prezzi per 3 anni e focus sull’aumento di utilità percepita, non di ticket. I 1.000$ del 2017 hanno aperto una prateria, ma oggi il consumatore capisce il gioco.
- Rimettere il design al centro del processo, non a valle dei vincoli finanziari. Il caso Ive non è nostalgia: è il promemoria che la cultura decide la traiettoria del prodotto.
- Servizi meno “rendita”, più “motore”: usare i servizi per abilitare cose che l’hardware da solo non può (AI privata, identità digitale, sicurezza), riducendo la dipendenza da tasse d’intermediazione contestate dai regolatori.
Cook ha fatto di Apple una macchina di utili impeccabile. Ma la creazione di valore—quella che trasforma un’azienda in un riferimento culturale—non è uguale all’estrazione di valore. Oggi Apple è più vicina alla seconda. Il paradosso è che ha mezzi, talento e fondamenta consolidate per tornare a dettare l’agenda, non a inseguirla. Basterebbe tornare a una regola semplice: prima il prodotto, poi il resto. Jobs l’aveva capita. È ora che Apple la ricordi.



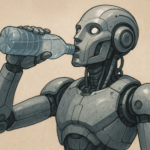

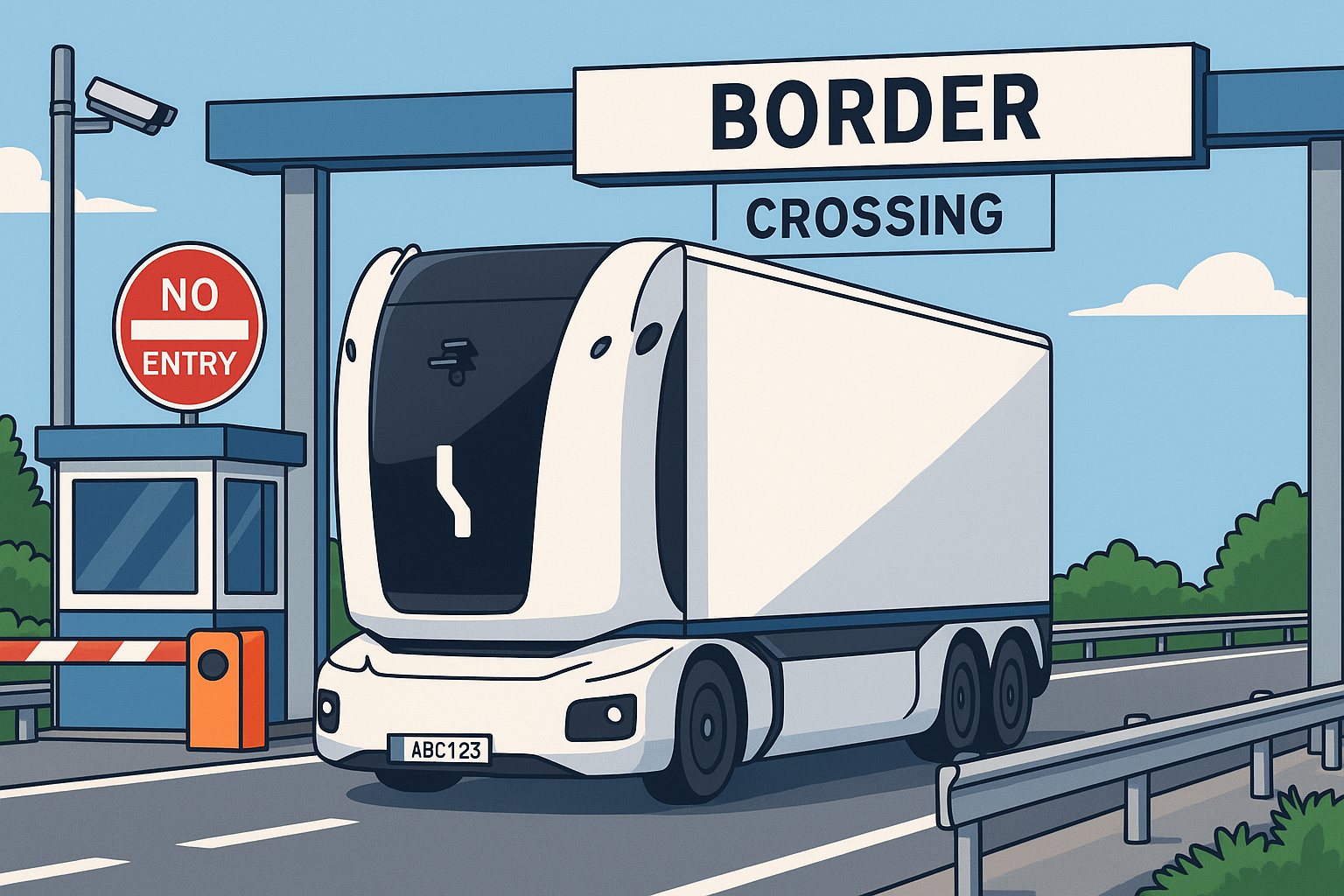
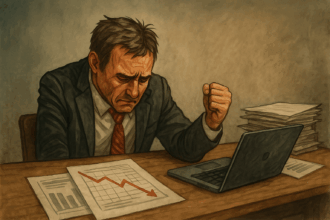
Un commento